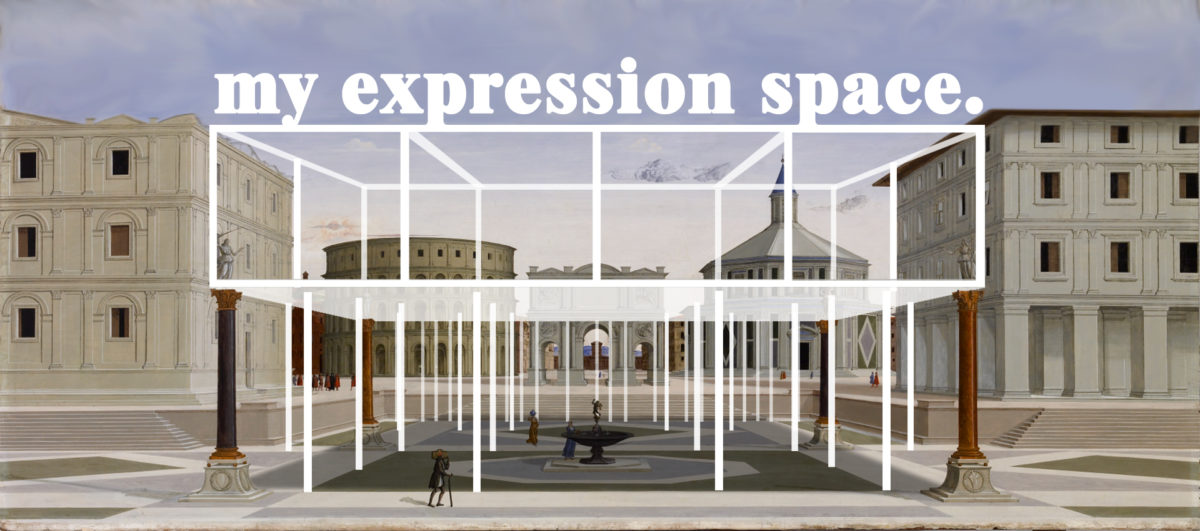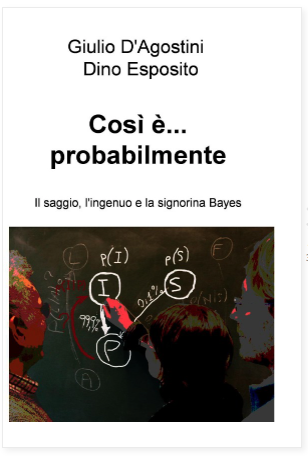Lavoro: nel terzo millennio come suona questa parola?
Si può parlare di lavoro in molti modi e il libro di Stefano Massini, edito dalla Il Mulino, intitolato “Lavoro” esplora i meandri di questo concetto da una prospettiva del tutto inedita.
Leggendo questo testo, sembra decisamente di essere seduti in una platea teatrale, di fronte un palco, sul quale Massini con maestria e semplicità racconta le varie sfaccettature di questa parola diventata nel tempo un vero e proprio concetto.
Stefano Massini, consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano, ha analizzato nei vari capitoli di questo il libro il significato intrinseco e profondo di questa parola, mantenendo uno stile simpatico, nonostante scriva di una cosa al quanto difficile.
Usando figure storiche conosciute dai più, siano esse realmente esistite e nate dalla penna di indiscutibili scrittori, rappresenta agli occhi di tutti un sentiero tanto impervio quanto suggestivo.
Citando personaggi che vanno da Cicerone a Prometeo, da Karl Max a Sant’Agostino, da Robin Hood al Dr. Jekyll e Mr Hyde, l’autore delinea l’idea e il senso del lavoro associandolo ogni volta ad un particolare aggettivo qualificativo.
“Una parola scura”.
Si delinea la considerazione che nel tempo il lavoro è stato oscurato da una patina opaca, riportando il pensiero umano dal disincanto all’aspetto critico e polemico, andando a coincidere in senso figurativo con una ferita scoperta e dolorante.
“Una parola complessa”.
Lavoro è un sostantivo che identifica tanto una azione che il suo prodotto o quel luogo in cui le azioni vengono svolte per arrivare a produrre un determinato elemento, più o meno aleatorio, con fatica e costi non solo economici ma anche fisici e mentali.
“Una parola vitale”.
“Lavoro quindi sono” è un postulato molto concreto e fisiologico che identifica come ognuno di noi lavori per la necessità di procurarsi un sostentamento e pochi lo fanno per esclusivo piacere. Si esplicita così una delle tante corruzioni della parola lavoro, che perde il suo essere un naturale bisogno per diventare addirittura un valore di eccezione e, in certi casi, di eccellenza.
“Una parola ingombrante”.
Il lavoro, nel tempo, ha perso il suo essere strumento per sopravvivere ed è diventato quasi l’identificativo di uno status simbol, venendo percepito come un dovere con l’esclusiva funzione di maturare un reddito, svuotato del suo valore più intrinseco a livello relazionale.
“Una parola tecnica”.
E’ innegabile che la tecnologia sia diventato un elemento portante della nostra società da terzo millennio. A livello concettuale e fattivo la tecnologia ha assunto un ruolo (apparentemente) imprescindibile, radicale e irreversibile, per cui sembra quasi che senza più tecnologia non esista lavoro o tipologia di esso normalmente esercitabile. In modo del tutto speculare, l’inquietante presenza della tecnologia sempre più qualificata disarciona l’essere umano cosciente e pensante dalla funzione lavorativa, con la deificazione della macchina a scapito della manodopera umana.
“Una parola straniera”.
Nella nostra era di contaminazione lanciata al galoppo, ci si imbatte sempre più spesso in declinazioni di provenienza anglosassone di tutto ciò che è e riguarda il lavoro. Il rischio concreto di perderne i veri e tradizionali significati, con tutto quello che storicamente comportano, allenta il più profondo legame tra mestieri e territorio, snaturando gli uni e gli altri: work, job, flexibility on job, job on call, voucher work, job sharing, work in progress, task forces, think thank e così via.
“Una parola scordata”.
Si, perchè un tempo il mestiere era un crisma difficilmente scalfibile, un momento essenziale per essere e sentirsi uomini e donne liberi. Oggi il lavoro viene percepito come un obbligo, quasi un peso, un qualcosa di limitativo, sinonimo di sforzo, ingiustizia sociale e mal digerita sottomissione. Quando c’è.
In effetti, per quanto anacronistico possa sembrare, in una Repubblica fondata sul lavoro si assiste alla contrapposizione tra il lavoro e i diritti del lavoratore spesso considerati accessori, se non inutili in certi malaugurati casi. Un lavoro agognato per il quale, sfido a dire diversamente, si troverà sempre quello più disperato e disposto a scendere al compromesso peggiore, a scapito di sé stesso e della retribuzione, pur di lavorare.
Nella fitta giungla del lavoro, dei lavoratori, del senso di oppressione di chi lo ha e la disperazione di chi lo perde o la ricerca spasmodica per averne uno, appare chiaro come la sintassi del lavoro abbia perso la sua grammatica umana.
Perdendo lei è come se si fosse perso tutto quel senso di speranza nel futuro, accrescimento personale, familiare e professionale, nonché la voglia di migliorare se stessi ed ambire sempre più in alto, per essere delle persone migliori.
Massini conclude il suo libro con l’inquietante paradigma che tutti noi abbiamo almeno sentito una
volta per televisione, dove le persone di Taranto dicevano dell’Ilva “Uccide, certo, ma ci dà da vivere”.
Un frammento contraddittorio e disperato dell’idea del lavoro, che prima aveva un senso, rappresentava qualcosa di veramente importante e custodiva un vago sentore di origini preziose, ma che oggi è più vicino ad un ricordo lontano e sbiadito.
Francesca Tesoro