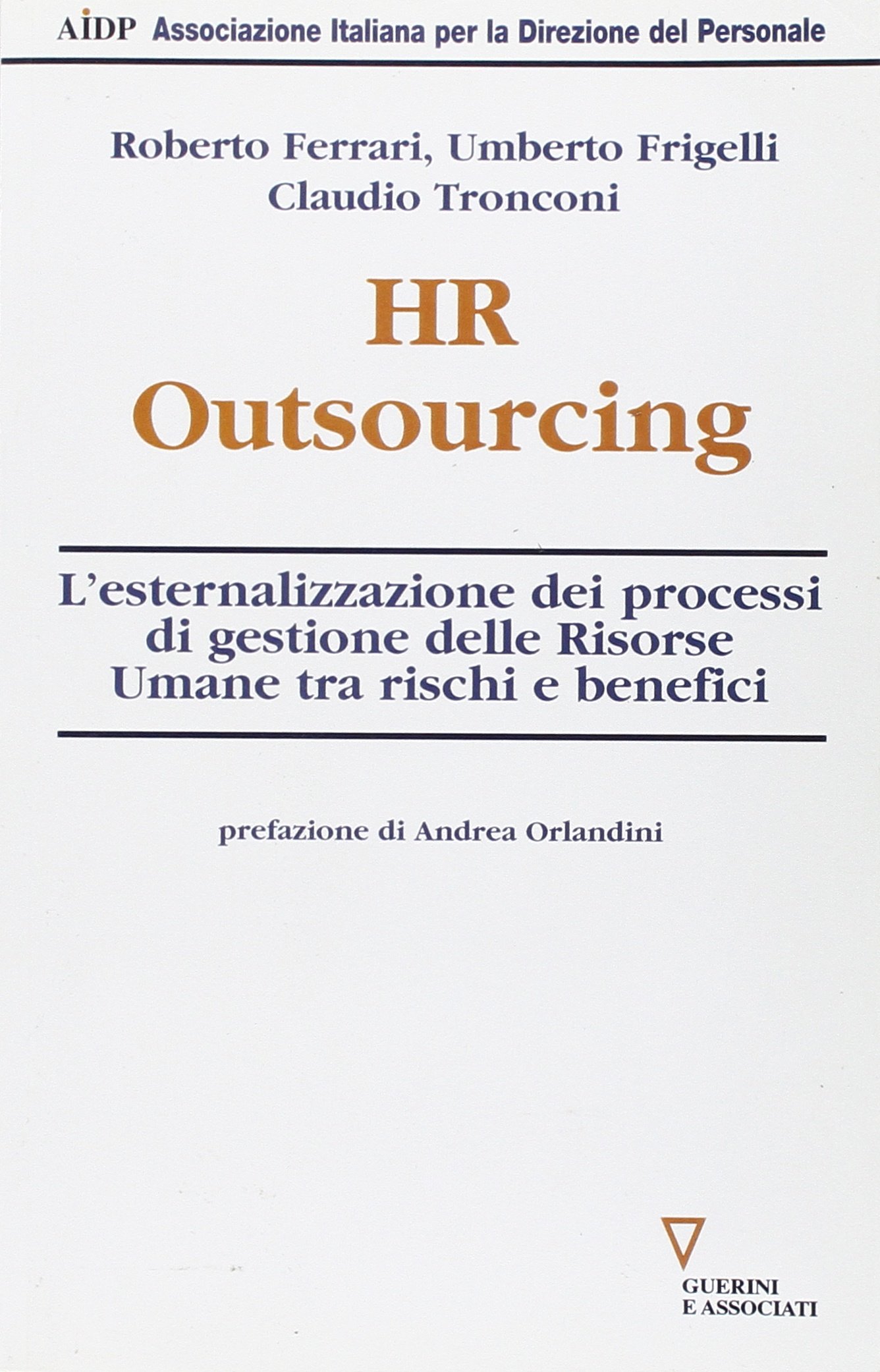
Parlando di azienda e impresa, welfare ed evoluzione del sistema imprenditoriale, la nostra attenzione si è concentrata sul libro scritto da Roberto Ferrari, Umberto Frigelli e Claudio Tronconi, edito dalla Guerini e Associati in collaborazione con la AIDP, Associazione Italiana per la Direzione del Personale, intitolato “HR Outsourcing – L’esternalizzazione dei processi di gestione delle Risorse Umane tra rischi e benefici”.
Il volume può essere definito un vero manuale in materia grazie anche al suo altissimo livello tecnico che, attraverso dati empirici e casi specifici frutto di una ricerca articolata, ha messo in luce le motivazioni e gli obiettivi che hanno spinto le aziende a ricorrere alla esternalizzazione delle attività e dei servizi riguardanti il settore HR.
Se il tema dell’esternalizzazione dei processi di gestione delle Risorse Umane ha ormai raggiunto una consolidata esperienza e un concreto utilizzo a livello aziendale, mancava nella realtà dei fatti una base teorica che spiegasse il perchè di questa scelta e le conseguenze da essa derivanti, una linea guida che razionalizzasse e focalizzasse le best practices in HR.

Un progetto nato da lontano….
Come scrive Claudio Tronconi (AIDP Lombardia) nell’introduzione, questo progetto è nato diversi anni prima rispetto la materiale pubblicazione.
Nel giugno 2005 Roberto Ferrari, Direttore Area HRM in Outsourcing dell’ISMO (società di formazione e consulenza), partecipa con il suo articolo “L’outsourcing per la gestione e lo sviluppo dele Risorse Umane” ad un numero della rivista Direzione del Personale.
L’anno seguente, Tronconi e Ferrari si incontrano ad un congresso nazionale della AIDP – Associazione Italiana per la Direzione del Personale – parlano di quell’articolo e, nella stessa occasione, incontrano Marco Guerci, al tempo assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano.
Sul finire del 2006 Umberto Frigelli, Responsabile del gruppo Ricerca AIDP Lombardia presenta una ricerca sulla “Innovazione per la gestione delle Risorse Umane”.
Nel 2010, viene creato un gruppo di lavoro misto formato da AIDP (Frigelli e Tronconi), ISMO Group (Ferrari ed altri) e il Politecnico di Milano (Guerci) i quali, partendo da un lavoro di analisi della letteratura in materia di allora, hanno definito il campo di ricerca sulla quale avrebbero voluto operare, data la necessità di tracciare un confine delle prassi di gestione delle Risorse Umane nelle aziende. Perciò si sono concentrati sull’Outsourcing come quel “processo attraverso il quale le aziende assegnano stabilmente a fornitori esterni la gestione operativa di una o più funzioni” che prima erano svolte all’interno delle singole aziende.

Una volta definito questo campo di ricerca, grazie al coinvolgimento di ISMO, sono stati intervistati sette direttori Risorse Umane che avevano già intrapreso e consolidato questo processo per identificare i rischi e i benefici dei processi di Outsourcing ed avere una raccolta di best practices e case studies.
Successivamente, attraverso dei focus group tra aziende e consulenti interessati a questo tema, sono state confrontate le opinioni e le situazioni di chi aveva realizzato progetti di Outsourcing per favorire lo scambio di esperienze sugli obiettivi da raggiungere, valutare i benefici e considerare i rischi che si sarebbero dovuti affrontare e, di conseguenza, identificare i fattori critici di successo grazie all’incontro di consulenti differenti tra loro per tipologia ed approccio alla questione.
Infine, AIDP – storica associazione di Manager con ruoli direttivi, di responsabilità e di consulenza nel settore HR presso privati e istituzioni pubbliche – forte dei suoi tremila soci, ha chiesto ad alcuni di loro, precisamente a centoquindici manager, di esprimere opinioni sul tema attraverso la compilazione di un questionario.
Il 25 novembre 2010, AIDP Lombardia ha organizzato il convegno di presentazione di questa ricerca che, poco dopo, è stata trascritta per intero nel libro di cui stiamo parlando.
….Una ricerca con aspetti teorici, concettuali e pratici….
Il punto nodale di questa ricerca è stato il contributo dell’HR alla competitività delle organizzazioni e le specificità identificate dell’esternalizzazione nel campo delle Risorse Umane, valutando le implicazioni manageriali per le imprese italiane che sono diventate l’obiettivo finale del lavoro.

Perchè questa ricerca fosse valida è stato necessario valutare gli Aspetti Concettuali e Teorici, affrontati nel capitolo uno. Così, introdotti gli elementi caratterizzanti del fenomeno dell’outsourcing e i benefici derivanti, sono stati analizzati i contesti di diffusione dei processi e delle attività di gestione delle HR, è stato approfondito l’impatto che l’esternalizzazione della gestione HR ha sulle organizzazioni, concentrandosi sulle motivazioni e sulle scelte alla base del make or buy, sui modelli teorici di riferimento e sulle competenze indispensabili per la gestione di questo processo.
La ricerca sull’HR Outsourcing nelle imprese, come riportato nel secondo capitolo, si è dunque concentrata sulla comprensione delle dinamiche che spingono le aziende ad esternalizzare questo settore, trovando la risposta nella necessità di assecondare e seguire il processo evolutivo che coinvolge le Direzioni Risorse Umane, proiettate ad apportare sempre un contributo strategico senza compromettere l’efficienza e l’efficacia dei propri servizi.
Nell’ultimo capitolo dedicato alle Prospettive emerge ciò che è richiesto alle Direzioni delle Risorse Umane e cioè la capacità di evolvere ad una visione professionale consapevole del business capace di influenzare i comportamenti delle persone, facendo di questi un vincente elemento di strategia aziendale anche e soprattutto alla luce dei cambiamenti del sistema economico e dell’innovazione tecnologica.

….Per definire Benefici, Rischi e Obiettivi dell’HR Outsourcing.
Marco Carcano, autore della postfazione, sostiene che questo libro racchiude in sé una buona ricerca per cinque ragioni – e non gli si può dar che ragione – perchè:
-
- non ha trascurato gli approfondimenti, soprattutto metodologici, che sono alla base della pratica dell’outsourcing;
- ha usato una strumentazione di ricerca sociale, attraverso la materiale partecipazione dei soci AIDP, l’utilizzo dei case studies e dei focus group;
- ha prodotto una base teorica;
- ha creato un team di lavoro interdisciplinare sia dal punto di vista delle competenze che delle esperienza professionali;
- nel tempo della ricerca sono stati correttamente distinti gli HR Outsourcing, HR Consulting e Temporary Management.
È stata palesata la necessità di procedere con gradualità e rigore tanto nella fase di impostazione che nella fase di implementazione del processo di HR Outsourcing, fornendo altresì uno sfondo di riferimento circa le relazioni industriali, l’impresa e il lavoro quale elemento che va tutelato anche a fronte della trasformazione del suo ruolo, il tutto in una determinata complessità sistemica.

Dai risultati della ricerca emergono chiaramente i benefici e i rischi dell’HR Outsourcing.
I benefici possono essere classificati:
-
-
- di efficacia quando riguardano la focalizzazione sulle attività strategiche, l’accesso e lo sviluppo di nuove competenze specialistiche ed aggiornate, l’accesso a tecnologie avanzate e l’incremento della flessibilità, senza dimenticare il know-how;
- di efficienza quando si parla di riduzione dei costi, del time consuming, degli investimenti e della razionalizzazione del personale interno.
-
Al contrario sono stati definiti come rischi il possibile abbassamento del livello dei servizi che si ricevono se non si contratta primariamente con i partners che andrebbero a gestire il servizio esternalizzato ciò che si vuole, il lasciare spazio ad eventuali comportamenti opportunistici, la perdita di controllo o le aspettative disattese sui processi se non vengono impostate operazioni di double-check con i fornitori e, da ultimo ma non meno importante, le possibili resistenze all’interno delle aziende stesse derivanti dal processo di reengineering che è alla base dell’HR Outsourcing.
Infine, va segnalato un ulteriore aspetto messo in luce da questa analisi. Ciò che infatti è risultato comune e maggiormente sentito dai differenti modelli e settori aziendali che hanno preso parte alla ricerca e che determinano la scelta di ricorrere all’HR Outsourcing, sono stati gli Obiettivi. Non deve certo apparire fuori luogo come il concentrarsi sulle attività strategiche aziendali, la riduzione dei costi, l’accesso a competenze specifiche e la razionalizzazione il personale interno diventino i traguardi da raggiungere nella scelta di percorrere la via dell’esternalizzazione.
Insomma, l’esternalizzazione dei processi di gestione delle Risorse Umane, appare una cosa estremamente vantaggiosa sotto diversi profili, ma bisogna preparare tutto alla perfezione, altrimenti si correrebbero solo inutili rischi.
Francesca Tesoro

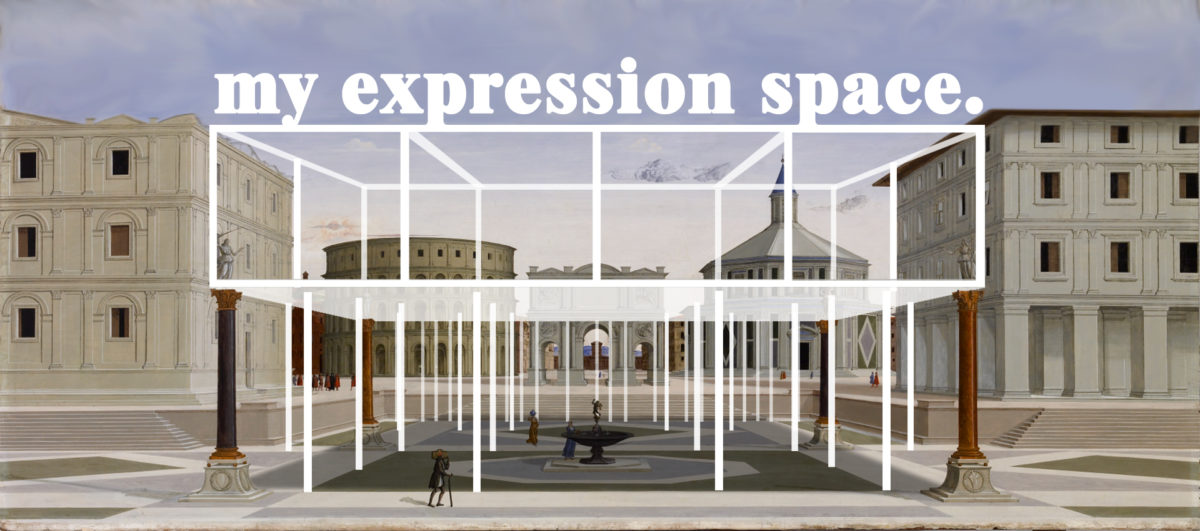





 Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato come fare positivamente ricorso all’improvvisazione sia durante un
Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato come fare positivamente ricorso all’improvvisazione sia durante un 




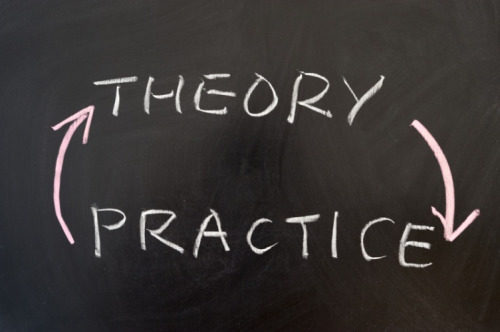


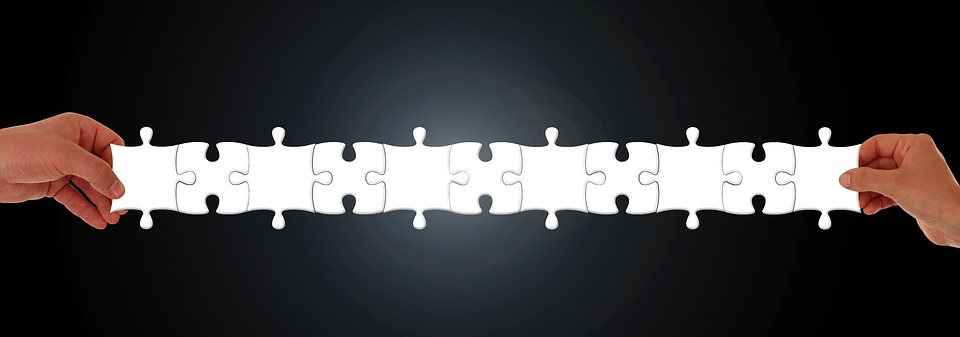

 Diventare scrittori di professione non è mai stato semplice. Né in passato, quando l’Editoria attraversava periodi più floridi, né adesso che, oltre alla crisi economica, l’avvento del digitale sta cambiando molte cose, generando sia nuove opportunità, sia momenti di confusione. Inoltre lo stretto legame che, senza dubbio, unisce la scrittura all’ispirazione fa sembrare quello dell’autore un mestiere senza regole, presumibilmente alla portata di tutti e che, quindi, non necessita di una grande preparazione specifica, oltre a un innato talento. Quando si pensa agli autori studiati sui banchi di scuola si fatica a capire se l’analisi dei testi che tutti gli studenti sono abituati a fare è solo frutto del lavoro dei critici e degli accademici o è realmente stato uno degli strumenti dell’autore stesso per ideare, rifinire e cesellare la propria opera.
Diventare scrittori di professione non è mai stato semplice. Né in passato, quando l’Editoria attraversava periodi più floridi, né adesso che, oltre alla crisi economica, l’avvento del digitale sta cambiando molte cose, generando sia nuove opportunità, sia momenti di confusione. Inoltre lo stretto legame che, senza dubbio, unisce la scrittura all’ispirazione fa sembrare quello dell’autore un mestiere senza regole, presumibilmente alla portata di tutti e che, quindi, non necessita di una grande preparazione specifica, oltre a un innato talento. Quando si pensa agli autori studiati sui banchi di scuola si fatica a capire se l’analisi dei testi che tutti gli studenti sono abituati a fare è solo frutto del lavoro dei critici e degli accademici o è realmente stato uno degli strumenti dell’autore stesso per ideare, rifinire e cesellare la propria opera.

 Di particolare utilità sono, oltre all’attenzione di entrambi questi autori per la costruzione dei personaggi come caposaldo trainante delle storie assieme alla loro appartenenza socio-culturale, da una parte le considerazioni di Edith Wharton sul punto di vista dal quale si affronta la narrazione, dall’altra la necessità per ogni scrittore, secondo Henry James, di possedere un taccuino di appunti assolutamente privato nel quale dare sfogo alla propria ispirazione prima di procedere alla stesura vera e propria.
Di particolare utilità sono, oltre all’attenzione di entrambi questi autori per la costruzione dei personaggi come caposaldo trainante delle storie assieme alla loro appartenenza socio-culturale, da una parte le considerazioni di Edith Wharton sul punto di vista dal quale si affronta la narrazione, dall’altra la necessità per ogni scrittore, secondo Henry James, di possedere un taccuino di appunti assolutamente privato nel quale dare sfogo alla propria ispirazione prima di procedere alla stesura vera e propria.




 Cosa ci fanno tre formatori aziendali al Circolo Polare Artico? No, non è una barzelletta, né la trama di un nuovo film nelle sale cinematografiche, ma il cuore di un appassionante diario di viaggio scritto dagli stessi protagonisti che, col medesimo coraggio che li ha portati ad avventurarsi tra i ghiacci del Polo, ogni giorno si addentrano nella Giungla che spesso può diventare il lavoro in un’azienda.
Cosa ci fanno tre formatori aziendali al Circolo Polare Artico? No, non è una barzelletta, né la trama di un nuovo film nelle sale cinematografiche, ma il cuore di un appassionante diario di viaggio scritto dagli stessi protagonisti che, col medesimo coraggio che li ha portati ad avventurarsi tra i ghiacci del Polo, ogni giorno si addentrano nella Giungla che spesso può diventare il lavoro in un’azienda.











 Luca Zingaretti si è calato nei panni dell’ingegnere Adriano Olivetti ripercorrendo alcune tappe fondamentali della sua vita raccontate nella Fiction “Adriano Olivetti. La forza di un sogno”, prodotta da Rai Fiction e Casanova Multimedia e andata in onda su Rai Uno il 28 e 29 ottobre 2013, con un cast d’eccezione, composto, oltre che dall’attore romano, da Stefania Rocca, Massimo Poggio, Francesca Cavallin e da Francesco Pannofino.
Luca Zingaretti si è calato nei panni dell’ingegnere Adriano Olivetti ripercorrendo alcune tappe fondamentali della sua vita raccontate nella Fiction “Adriano Olivetti. La forza di un sogno”, prodotta da Rai Fiction e Casanova Multimedia e andata in onda su Rai Uno il 28 e 29 ottobre 2013, con un cast d’eccezione, composto, oltre che dall’attore romano, da Stefania Rocca, Massimo Poggio, Francesca Cavallin e da Francesco Pannofino.


